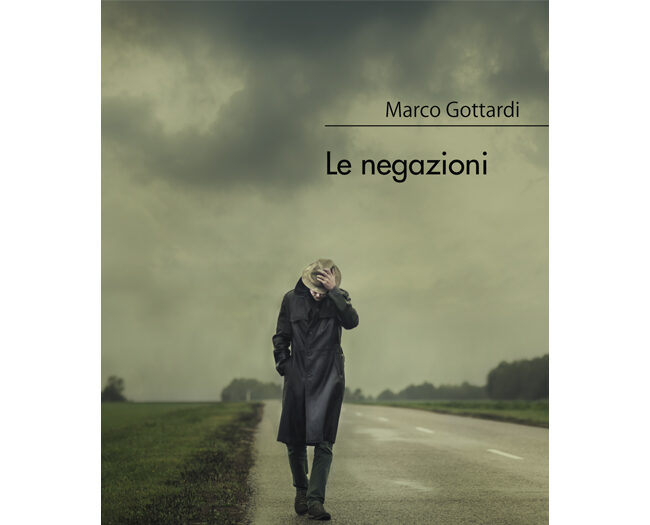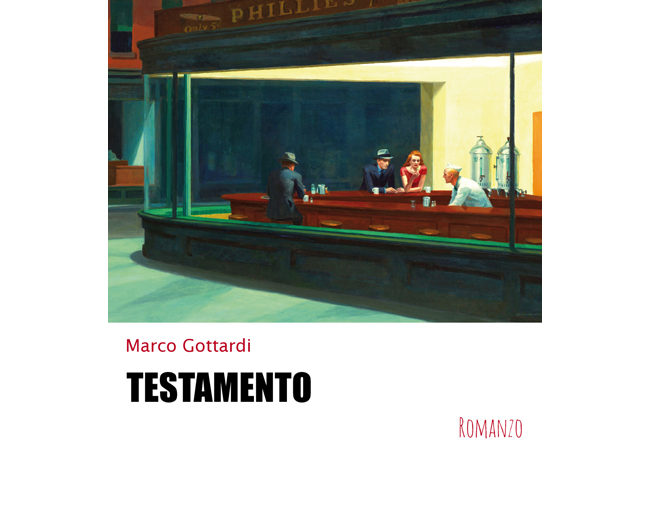Comparso su Il Cortese, anno VI, nr. 5, dicembre 2008, nella rubrica “L’intervista”. Leggi l’articolo
IL MIO RICORDO DI ENZO MANDRUZZATO
La prima volta che vidi Enzo Mandruzzato fu in un caldo pomeriggio di fine estate del 2008. Al tempo, ancora studente alla facoltà di Lettere dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, lusingavo il mio vezzo per la scrittura lavorando al Cortese, rivista finanziata da un grosso imprenditore del Padovano nella quale, tra decine di pagine patinate consacrate agli orpelli del lusso, trovava spazio un angolo della cultura, un piccolo orticello che curavo con passione unitamente alle mie aspirazioni letterarie. Fui io a proporre in una riunione di redazione di intervistare il professor Mandruzzato, anche se in verità non conoscevo a fondo la sua opera né, tantomeno, la sua figura di intellettuale e uomo di cultura. Avevamo usato un suo libro al corso di Letteratura Italiana del professor Belloni, amico di Mandruzzato e poi correlatore alla mia tesi di laurea specialistica sulla lirica amorosa del Duecento. Tutto qui. E fu durante quel corso che sentii per la prima volta il nome di Enzo Mandruzzato e che per la prima volta lessi, anzi studiai, un suo recente libro sulla poesia. Ma quando mi recai a casa sua per intervistarlo, di lui sapevo poco o nulla. Sapevo che era un grande. Che forse non aveva vissuto da grande, ma che aveva scritto come un grande. Era un colosso, uno da best seller. Anche se i riflettori di una mondanità troppo spesso vacuamente ciarliera e superficiale non ne avevano fatto, per fortuna, un surrogato d’intelligenza da esporre nei salotti domenicali. Forse privandolo di una buona parte di encomi doverosi, ma salvandolo al contempo dalle derive di un gradimento plebeo difficilmente conforme alle aspirazioni di uno spirito elevato.
Citofonai al civico 25 di via Palestro alle 15 in punto, con mezz’ora di anticipo sull’appuntamento prefissato telefonicamente. Quando entrai in casa, capii che avevo quasi interrotto il pranzo o che il professore e sua moglie avevano frettolosamente ingollato l’ultima forchettata di pasta per farmi accomodare senza attese. Inutile dire che mi sentii in imbarazzo per quell’intromissione fuori orario. In ogni caso, con estrema cordialità, Mandruzzato mi fece strada in salotto dove poco più tardi la signora servì il caffè. Un caffè che Mandruzzato si dimenticò di bere perché subito la nostra discussione si fece un fiume di parole in piena che, evidentemente, rappresentava per entrambi un’attrattiva maggiore rispetto a una tazza di caffè. Gli scaffali attorno alla stanza erano pieni di libri e la luce entrava soffusamente dalla tapparella semiabbassata, conferendo all’ambiente un’atmosfera pacata e indolente, nella quale l’intervista assunse naturalmente sfumature intime e quasi familiari. La pacatezza e la precisione con la quale Mandruzzato rispondeva alle mie domande lo facevano assomigliare a un libro parlante, ma un libro di quelli rivisti e corretti centinaia di volte, senza una sbavatura, una parola fuori posto, un suono che non si orchestrasse armoniosamente con gli altri. Disquisiva in una forma così ammaliante che sembrava avesse conosciuto in anticipo le domande e si fosse bellamente preparato le risposte più seducenti. In verità, Mandruzzato possedeva una facondia e un’eloquenza tali che lo si sarebbe ascoltato per ore anche se avesse discettato di foglie secche. Nelle sue parole, e persino nel suo aspetto, con quella barba bianca e i capelli voluminosi tirati all’indietro, c’era un’innegabile armonia, un ordine e una proporzione d’ascendenza classica, per così dire, che non facevano altro che confermare come quell’indomito traduttore di opere greche e latine facesse più parte del mondo antico che di quello contemporaneo. E del resto, sul fatto che i secoli passati fossero stati, culturalmente e letterariamente, migliori del nostro, e che avessero prodotto opere immortali portatrici di valori universali oggi smarriti, su questo eravamo in piena sintonia. Non si perdona facilmente al proprio tempo l’incapacità di produrre classici, né si accetta di buon grado il suicidio della civiltà, per dirla col titolo di un libro che Mandruzzato, al tempo, aveva in cantiere. E non è questione di passatismo o nostalgia, è questione di gusto, direi quasi di stile.
Ricordo che, anche in forza di questa condivisa visione del mondo, si creò tra di noi una certa empatia; insomma, eravamo due scrittori e critici, e sebbene con autorità profondamente diversa parlavamo pur sempre la stessa lingua, ed eravamo entrambi innamorati della letteratura e della poesia. Della buona letteratura e della buona poesia, naturalmente. Perché quando finimmo a parlare del Leopardi poeta, che entrambi consideravamo sopravvalutato, per dirla eufemisticamente, ci scoprimmo intenti a denigrare congiuntamente un titano, e finì che ci facemmo persino quattro risate. Non me ne vogliano i tanti studiosi e ammiratori del recanatese, ma in quell’occasione fu così. Ed essere d’accordo con un grande sul giudicare negativamente un altro grande fu per me quasi un entrare (dalla porta di servizio, s’intende) “fra cotanto senno”, essere dei loro, essere uno scrittore vero. E visto che mi consideravo un buon poeta, non potei esimermi dal chiedere a Mandruzzato un’opinione (e nei piani c’era anche un’eventuale richiesta di prefazione) su una mia raccolta inedita di versi che gli avevo trasmesso e che volevo pubblicare. Parlammo di questo alla fine dell’intervista, e lui con grande semplicità e profondità mi disse: “io non la pubblicherei, è troppo pretenziosa.” Smontò in modo indolore una buona parte della mia autostima, ma aveva ragione… oggi quella raccolta è tutt’ora inedita e non vedrà mai la luce. Grazie professore…